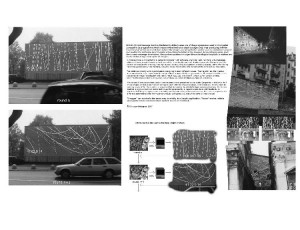Mario Costa è uno dei protagonisti del dibattito internazionale sull’arte neo-tecnologica, nel quale ha introdotto concetti come “sublime tecnologico”, “estetica della comunicazione”, “blocco comunicante”. Tra i suoi libri più noti e tradotti, Il sublime tecnologico (Castelvecchi, Roma 1990). Fondatore e promotore di Artmedia, prima manifestazione italiana sulle arti neo-tecnologiche, è ordinario di Estetica all’Università di Salerno e professore incaricato di Etica ed Estetica della comunicazione all’Université de Nice–Sophia Antipolis (Deess).
1. Arte tecnica, tecnologica e neo-tecnologica
Maurizio Bolognini: Nel tuo ultimo libro, “Dimenticare l’arte” (Angeli, Milano 2005), analizzi le categorie dell’estetica nelle diverse fasi della storia dell’arte e della tecnica. Il rapporto tra tecnica e produzione artistica è la questione centrale, che affronti distinguendo gli strumenti (e la loro co-appartenenza alla mano) e le macchine, e individuando tre epoche diverse: 1) l’epoca della produzione tecnica (in particolare pittura e scultura), che inizia con le incisioni del paleolitico e finisce con la nascita della fotografia; 2) l’epoca tecnologica (fotografia, televisione, cinema, fonografo, magnetofono, telefono…), che nei primi decenni del XX secolo determina la trasformazione dell’arte in avanguardia artistica, e segna la crisi delle teorie estetiche tradizionali; 3) infine l’epoca della produzione neo-tecnologica (computer, reti, realtà virtuale…), che provoca una rivoluzione legata innanzitutto al modo di manifestarsi della “presenza”, che rimette in discussione le nozioni di spazio, di tempo e di corpo.
Mentre riconosci all’estetica di aver cercato di superare le categorie dell’epoca tecnica attraverso una teoria, sia pure incompiuta, dell’arte tecnologica, sarebbe ancora inadeguata la comprensione dell’arte neo-tecnologica: la concezione dell’arte come “linguaggio” non poteva che nascere con la produzione tecnologica, a partire dal cinema e dalla fotografia, ma a questo periodo avrebbe dovuto limitarsi; solo le tecnologie – sostieni – “traducono” la cultura e dunque danno luogo a un “linguaggio”, mentre con le neo-tecnologie la nozione di linguaggio si perde necessariamente in quella di “fisiologia della macchina”. Come definisci questi tre periodi? Che differenza c’è tra tecnica, tecnologia e neo-tecnologia? E cosa significano per l’arte e l’estetica?
Mario Costa: È necessaria una premessa. Ci sono nell’estetica dei luoghi comuni dati come verità indiscutibili e che è invece opportuno discutere. Quali sono: a) che la tecnica è una componente marginale dell’arte e che questa si fa utilizzando indifferentemente ogni tecnica; questo punto di vista si è spinto a volte fino a considerare del tutto innecessaria la stessa realizzazione dell’opera (da Schleiermacher a Croce), ma anche quando non si è giunti a questa posizione estrema e paradossale, la tecnica è stata sempre ritenuta come puro “tramite” di qualcosa che le resta estraneo: l’Arte come prodotto spirituale; b) che, e questo sul piano più generalmente filosofico, esiste uno sviluppo lineare della tecnica che va dalla più lontana preistoria ad oggi, e che tra le varie epoche della tecnica esiste soltanto una differenza di grado e non di qualità.
Questi luoghi comuni, io sostengo, sono stati estremamente perniciosi e hanno generato nell’estetica confusioni e incomprensioni di ogni tipo. Il mio punto di vista è un altro: a) la produzione artistica è sostanzialmente radicata nella tecnica, è questa che la fonda (ne è il fondamento) al punto che la storia dell’arte appare piuttosto come una storia delle tecniche o, meglio, della estetizzazione delle tecniche; b) non esiste uno sviluppo lineare tra le tecniche e il loro divenire è piuttosto caratterizzato da “catastrofi”; da questo punto di vista bisogna fare una distinzione ben netta tra “tecnica”, “tecnologia” e “neo-tecnologie” perché si tratta di epocalità diverse, dal punto di vista antropologico e da quello del senso che in ciascuna di esse assume la produzione artistica.
M.B.: Cosa distingue queste diverse epoche della tecnica?
M.C.: Ti posso rispondere quasi riportando le parole del libro, ma senza argomentare, come invece faccio nel libro, quelle che qui sembrano affermazioni un po’ apodittiche.
La tecnica – sembra dominata dal principio della individuazione degli strumenti; è l’epoca della mano; gli oggetti tecnici sono legati al bisogno e rispondono ad esso; fanno parte della cultura nel senso che sono una parte della cultura stessa (gli antropologi hanno potuto parlare di essi come di una “cultura materiale”); sono fortemente individualizzati, non nel senso in cui Simondon intende questo concetto: sono individualizzati nel senso che sono degli “individui” stabili, immutabili e indipendenti: “L’utensile […] È là, separato dal resto dell’universo”, “L’artista che incide il legno, batte il metallo, modella l’argilla, scolpisce il suo blocco di pietra, tramanda fino a noi un passato dell’uomo, un uomo antico senza il quale non esisteremmo. Non è mirabile vedere tra noi, nell’età della macchina, tale ostinata sopravvivenza delle ere manuali? […] È l’eterno ritorno di un passato formidabile, la riscoperta, senza ripetitività dell’ascia, della ruota, del tornio del vasaio”; gli oggetti tecnici possono servire l’uno all’altro (la ruota serve al carro, al vasaio, al dispositivo idraulico…) ma non si interpenetrano e non si ibridano; non stabiliscono relazioni tra di loro; in essi forma e funzione si corrispondono e sono fatte l’una per l’altra; sono quelli più intimamente legati alla corporeità dell’uomo e da essa attivati.
La tecnologia – sembra dominata dal principio del familiarismo tecnologico; gli strumenti sono sempre meno legati al bisogno e si costituiscono in famiglie dando luogo a delle vere e proprie “saghe” familiari nelle quali, ad esempio, ci sono storie anche drammatiche di individui che si affermano e di altri che scompaiono; gli oggetti tecnologici crescono stabilendo rapporti tra di loro (è il momento della “ibridazione” indagato da McLuhan); essi procedono per sequenze tecno-logiche (la fotografia, la diapositiva, la fotocopia… il cinema muto, il cinema sonoro, il cinema a colori, il cinema stereoscopico, stereofonico, tridimensionale…) e per ibridazioni; più che far parte della cultura e costituirla, la traducono; forma e funzione non si corrispondono; con essi comincia un processo di marginalizzazione dell’uomo. Per gli oggetti tecnici, e ancora per quelli tecnologici, vale il concetto mcluhaniano di estensione o di protesi.
Le neo-tecnologie – hanno la tendenza a costituirsi in blocchi e a formare degli ipermedia; crescono su sé stesse, al di fuori della cultura e tendono a dissolvere la cultura stessa; l’uomo è del tutto marginale ed il suo ruolo è sostanzialmente quello di far funzionare i diversi blocchi neo-tecnologici; le neo-tecnologie non sono più estensioni o protesi, nel senso mcluhaniano, ma estroversioni separate dei funzionamenti di base dell’umano che tendono progressivamente a farsi autonome e sé-operanti.
Come si vede, già i termini da me adoperati per i tre periodi della evoluzione degli strumenti: l'”individuazione”, il “familiarismo” e il “blocco”, indicano una tendenza degli strumenti prima a crescere e a differenziarsi, poi a stabilire relazioni tra di loro e a perfezionarsi selettivamente, e infine a chiudersi su se stessi; tale mi sembra la più realistica direzione dell’evoluzione.
M.B.: Consideriamo in che modo la transizione da un periodo tecnico all’altro può spiegare l’evoluzione delle arti.
M.C.: Per quanto riguarda le arti, stabilito che esse consistono sempre nella estetizzazione di una tecnica, ciò che bisogna considerare è il tipo di tecnica che viene estetizzata perché tra le “arti tecniche”, le “arti tecnologiche” e le “arti neo-tecnologiche” esiste una differenza profonda.
Le arti tecniche sono immediatamente legate al corpo e da esso sono messe in opera; qui “È il corpo umano […] che viene messo in gioco, che viene incaricato di esprimere la verità profonda” (Alain); è solo da questa circostanza che sono nate le categorie dell’estetica tradizionale: l’interiorità, l’espressione, il significato, l’ idea, lo stile, la personalità artistica, il simbolico, il genio, e così via.
Le arti tecnologiche si costituiscono sulla base di una mediazione rappresentata dalla presenza ineliminabile della macchina; questa (la “macchina” e non lo “strumento”), e solo questa, traduce l’esperienza nel senso in cui McLuhan intende questo concetto: le tecnologie sono “modi per tradurre un tipo di conoscenza in un altro […] Tutti i media […] hanno il potere di tradurre l’esperienza in forme nuove […] i media […] trasformano e trasmettono esperienza”; con le arti tecnologiche, insomma, si ha sempre e comunque a che fare con una traduzione del soggetto; è da qui che è nata la concezione dell’arte come “linguaggio” e nell’estetica è questo il momento nel quale si afferma la “semiotica”: il luogo prima dominante del “soggetto” viene sostituito dai “linguaggi” e dal “testo”.
Le arti neo-tecnologiche segnano la fine di ogni estetica dell’io, del soggetto e dei linguaggi, e si risolvono, sempre più chiaramente, in un’estetica dell’oggetto e della macchina sé-operante.
Questo significa ancora che le categorie forti della nuova estetica neo-tecnologica sono l’ “esteriorità”, i “significanti”, il “non-soggetto” e la “fisiologia della macchina”.
M.B.: Le spiegazioni legate alle tendenze evolutive della tecnica possono sovrapporsi a quelle interne all’arte, con influenze diverse a seconda dei casi e dell’orizzonte temporale considerato (breve, lungo o lunghissimo). Un momento cruciale nella storia dell’arte del XX secolo è stata la Seconda avanguardia. Come analizzi questo momento? In quale misura l’uscita dal quadro, l’installazione, la performance, si possono spiegare con riferimento alla storia e alle logiche interne dell’arte, o sono figlie anche dello sconquasso determinato dalla transizione tra un periodo tecnico e l’altro?
M.C.: Ho analizzato tutto questo soprattutto in un altro mio libro, “L’estetica dei media”, pubblicato nel 1990 e poi ripubblicato, accresciuto di molto, nel 1999, ma molte altre ricerche andrebbero fatte. Le trasformazioni legate alle logiche interne all’arte, come tu dici, sono trasformazioni di superficie rispetto a quelle indotte dalle nuove situazioni tecniche, poi tecnologiche e poi neo-tecnologiche: la storia della pittura cambia con l’avvento dei colori ad olio in tubetto e della fotografia. Ma è ancora poco. L’arte deflagra e viene scagliata fuori di se stessa dalle tecnologie. Il suo luogo mentale e materiale si fa introvabile e allora bisogna ricercarlo e rifondarlo in altre parti e in altre procedure. Le tecnologie lavorano ed operano occultamente in tutto questo: le azioni della land art sono sollecitate e diventano film e video, le performances si fanno presto video e media performances, le sperimentazioni linguistiche diventano presto poesia elettro-acustica, le istallazioni tematizzano, innanzitutto e anche loro malgrado, la preponderanza dei dispositivi e dei significanti tecnologici… e così via.
M.B.: Molti antropologi spiegano che una parte della tecnica (dai primi strumenti alle nanotecnologie) si trova dentro la cultura, nel nostro modo di stare nel mondo, mentre un’altra parte precede la cultura (l’attribuzione all’arte della capacità di sperimentare e anticipare nuove possibilità esistenziali trova anche in questo una legittimazione). La tua riflessione muove tuttavia da una prospettiva diversa: la cultura è dentro la tecnica, ed è la tecnica che decide del simbolico e del nostro modo di essere nel mondo. Questo significa che la tecnica opera dissolvendo la cultura e quindi la ricerca artistica? Che ruolo hanno allora la cultura e il simbolico?
M.C.: Noi non siamo più veramente in una cultura o in un simbolico ma, piuttosto e sempre di più, in un esterno e materiale mondo tecnologico, siamo semplicemente e soprattutto nella tecnica, una neo-tecnologia che, per altro, non agisce più solamente e prevalentemente sulle “cose” ma anche e radicalmente sull’uomo stesso (genetica, bio-tecnologie…). In altri termini, il simbolico ha cessato di essere quel sistema di significati capace di nascondere e ricomporre l’orrore di un mondo privo di senso; esso non offre più alcuna vera riparazione e alcun sicuro asilo. Il simbolico del nostro mondo è o “simulato”, come quello che la televisione costruisce quotidianamente, o “iper-reale”, come quello degli integralismi di ogni tipo. Potremmo anche dire che da un mondo costituito di “software” siamo passati ad un altro fatto di “hardware” e di questi soltanto.
In questa situazione la cultura ed il simbolico che noi abbiamo conosciuto si rivelano ed agiscono come forze regressive e distruttive, e questo perché tutte le nozioni/supporto sulle quali il simbolico si è antropologicamente edificato sono ora teoreticamente liquidate: l’identità, la presenza, lo spazio, il tempo, la cosa, la sensibilità, la ragione… assumono sempre di più lo statuto esistenziale ed ontologico deciso dalla neo-tecnologia e che ben poco ha a che vedere col passato. Faccio l’esempio della “cosa”: tutte le teorie della “cosa”, da Heidegger a Baudrillard, sono ora del tutto inutilizzabili: la neo-tecnologia ci mette di fronte a nuove cose digitali, vere e proprie epifaníe in grado già di per sé di perturbare fortemente tutti i modi nei quali la “cosa” è stata pensata; ma, ancora di più, che cosa sono i robot azionati dalla NASA che abbiamo visto muoversi su Marte?
di fronte a quali “cose” ci mette la tele-robotica? e quando le “cose” subiscono l’azione della tele-presenza, che cosa sono? e che cosa è, semplicemente, la televisione che mi sta davanti ma che comincia ad esistere veramente solo quando non è più presso di me ma in un altrove che non so collocare?
2. L’estetica nell’epoca neo-tecnologica
M.B.: Le immagini dell’epoca tecnologica, con il cinema e la televisione, perdono il rapporto con il referente e con l’Io che aveva caratterizzato la condizione pre-moderna. Lo statuto moderno dell’immagine si può riassumere nella nozione di “blocco immagine”, proposta da Virilio: nessuna immagine è indipendente dalle altre, ma confluisce in un blocco che ha un effetto “derealizzante”, cioè toglie realtà alle cose nell’istante in cui le trasforma in immagini. Nella tua analisi questo effetto viene considerato determinante nella fase tecnologica. Ma con le neo-tecnologie – sostieni – sarebbero altrettanto importanti i flussi comunicazionali e la tendenza delle stesse tecnologie comunicazionali a costituirsi in blocco, a integrarsi (grazie alla convergenza digitale) e crescere su se stesse, fino a diventare degli “ipermedia”: è ciò che chiami il “blocco comunicante”. In questi termini, i nuovi oggetti tecnologici non procederebbero solo per sequenze e per ibridazioni, ma rivelerebbero una tendenza a costituirsi in “blocco mediale”. Che differenza c’è tra la “multimedialità”, che continua a riempire le gallerie d’arte, le “ibridazioni” studiate da McLuhan, e il “blocco comunicante”? E quale arte è resa possibile dal “blocco immagine” e dal “blocco comunicante”?
M.C.: Per quanto riguarda i modi dell’essere-assieme dei media, la loro maniera di rapportarsi e interagire, è necessario distinguere questi tre concetti fondamentali: la “multimedialità”, l’“ibridazione” ed il “blocco”.
Nella nozione di “multimedialità” è sottintesa quella dell’“opera”, del “soggetto” forte che mette assieme ed attiva diverse fonti di informazione per “mettere in opera” il “significato”; la “multimedialità”, con tutto il suo implicito carico di trionfalismo umanistico, può esser fatta risalire alla nozione wagneriana di “opera d’arte totale” della quale, però, già Nietzsche aveva ben inteso l’impossibilità di andare al di là di una suggestiva “retorica teatrale”. Ed è quanto fanno, ora, tutte quelle cosiddette “installazioni multimediali” che, di fatto, occultano e degradano le tecnologie ad elementi di una mera scenografia.
In quanto al concetto di “ibridazione”, esso è, tra quelli individuati e definiti da McLuhan, certamente uno dei più interessanti ed ancora praticabili.
L’“ibridazione”, di cui McLuhan parla e di cui fornisce numerosi esempi, è, nel migliore dei casi, quella che si stabilisce tra media appartenenti ad ambiti sensoriali e a tecno-logiche ben distinte e differenti. E l’“ibridazione”, si noti, genera sempre nuova energia e nuove forme.
E dunque, una prima distinzione si impone: la mera giustapposizione di media, pur interagenti, che nulla aggiunge in termini di dinamica e di qualità dell’energia, e l’interpenetrazione dei media, una miscela esplosiva che sprigiona energie di tipo nuovo.
M.B.: Poi, accanto a queste, esiste un’altra maniera dello stare-assieme dei media, che è in qualche modo il contrario dell’“ibridazione” e che indichi come “blocco”.
M.C.: Infatti, qui un medium tende a costituire, appunto, un “blocco” con tutti gli altri media che funzionano, o che finiscono col funzionare, allo stesso modo e che hanno, o che finiscono con l’avere, la sua stessa essenza. Non si può più parlare, a questo punto, di medium ma di “blocco mediale”, di un complesso cementificato di media che agiscono secondo la stessa fisiologia e che, per ciò stesso, si rafforzano l’un l’altro. Si pensi al reciproco rimandarsi, che è ormai un fatto compiuto, di reti, cellulari, televisione, telefonia, ecc. oppure a ciò che alcuni chiamano “ubicomp”, cioè alla presenza diffusiva e pervasiva delle tecnologie numeriche.
La mia ipotesi è che in questa situazione la sperimentazione estetica non deve compromettersi col “blocco”, ma non nel senso che essa deve evadere in un’arte pre-tecnologica e neppure che deve tendere ad una “umanizzazione” delle tecnologie; la non compromissione consiste piuttosto nel far scoprire le carte al blocco stesso, mettendolo a lavorare a vuoto ed esibendo la sua nuda fisiologia.
M.B.: Le neo-tecnologie, telematiche e informatiche, determinano un mutamento estetico e antropologico, un cambiamento di paradigma. Nella tua analisi, il “sublime” (sublime naturale, nel Settecento, poi metropolitano e industriale, e infine tecnologico) rappresenta la nuova dimensione della ricerca estetica, nella quale gli oggetti neo-tecnologici si configurano come delle “aseità”, delle “epifanie ritratte in sé” – non più estensioni o protesi dell’umano, ma “estroversioni separate”, tendenti ad operare autonomamente.
Si tratta di categorie ormai entrate nel dibattito sull’estetica neo-tecnologica, che alcuni hanno anche messo a confronto con i “simulacri” di Baudrillard. Ma mentre questi rimandano allo svuotamento dei significanti prodotto dalla ipercomunicazione e dal carattere iperreale delle immagini, la tua analisi fa riferimento piuttosto al funzionamento vuoto dei dispositivi, alla loro stessa fisiologia. Da sempre, quando parli di comunicazione non ti riferisci ai contenuti ma ai dispositivi. Spieghi che in realtà anche la “estetica della comunicazione” non ha niente da comunicare, che sono flussi vuoti, senza informazione, quelli cui fai riferimento: quanto di più lontano si possa immaginare da qualsiasi ideologia comunicazionale.
Nella tua visione anche l’interattività e la bidirezionalità dei nuovi media sono poco più che un miraggio, qualcosa di molto elementare cui i primi artisti telematici hanno guardato con troppo entusiasmo. Tuttavia non possiamo escludere che la ricerca sulle tecniche di comunicazione di gruppo possa avere nei prossimi anni grandi possibilità di sviluppo. Perché anche questo non basterebbe a legittimare una prospettiva ancora umanistica nella ricerca artistica? E, viceversa, in che modo il sublime tecnologico tenderebbe ad accelerare la tendenza alla “disumanizzazione” dell’arte che individui già nel costruttivismo e in artisti come Gabo, Moholy Nagy e Duchamp?
M.C.: Da venticinque anni parlo dei prodotti di sintesi, del virtuale e delle reti, soprattutto ma non solo, come delle “epifaníe ritratte in sé” o come delle “aseità”; mi sono limitato a constatarne l’inedita e perturbante esistenza senza interpretarla troppo e cercando di ricavarne le conseguenze sul piano estetico e su quello più generalmente antropologico.
Ora, tra molti altri autori che si sono oggettivamente messi in sintonia con le mie riflessioni, trovo un analista junghiano di Monaco, Wolfang Giegerich, che, mettendosi dalla sua prospettiva e interpretando, scrive, in un testo di appena qualche anno fa (L’immaginale, 17/30, aprile 2001), le cose seguenti: si tratta per lui di liberarsi “dall’illusione (in apparenza così ‘naturale’) che lo sviluppo tecnologico sia, o potrebbe essere, al servizio di noi esseri umani e a nostro beneficio. Il progetto della tecnica ha i propri fini intrinseci e noi dobbiamo essere al suo servizio […] I benefici pratici […] e l’idea che lo scopo della tecnologia in sé sia quello di creare dei benefici per noi sono l’esca, per così dire, necessaria per sfruttare le nostre energie a favore del progetto della tecnologia […] possiamo invece considerare Internet e il World Wide Web come phainomena in cui l’’anima’ parla di sé […] Per Internet, per i computer e per i telefoni cellulari non siamo che l’interfaccia umana; siamo i loro allegati […] Viviamo (sempre di più) nel Web non in noi stessi […] La mente e la materia hanno scambiato le proprie nature. La mente ha assunto l’oggettività e l’esistenza indipendente della materia e la materia la sottigliezza e l’invisibilità della mente […] Internet […] È veramente un non-io. Non soltanto si sviluppa e si organizza per proprio conto, ma è anche al servizio di se stesso”, e così via.
M.B.: Forse Giegerich ha letto Heidegger.
M.C.: Forse, ma non credo che abbia mai letto quello che sto scrivendo, appunto, da venticinque anni, e dunque un riscontro così puntuale tra le mie antiche tesi e quello che lui ora scrive è quanto mai significativo. Capisci allora come, in questa situazione, ogni ipotesi artistica di assoggettamento o di umanizzazione delle tecnologie sia puramente velleitaria, tanto più che, a mio avviso e come ho cercato di dimostrare altrove, l’avanguardia più lucida aveva già ben compreso che il destino dell’arte stava nel rinsecchimento del significato e nella disumanizzazione.
M.B.: Vorrei infine mettere a fuoco il ruolo degli artisti in questi rivolgimenti. Riassumo la questione in due punti. Il primo riguarda la legittimazione teorica dell’arte, che è un problema per i critici e per gli estetologi ma lo è meno per gli artisti. Come artista posso considerare l’arte una semplice convenzione e tuttavia accettare che, sulla base di questa, ci sia un sistema (dei luoghi, un pubblico, un apparato di comunicazione) che, per quanto distorto, mi consente di fare delle cose che non avrebbero spazio altrove. Se anche l’arte non fosse altro che un “mito filosofico”, come sostieni, resterebbe tuttavia all’origine di una effettiva possibilità di sperimentazione.
La seconda questione riguarda la fisionomia degli artisti nell’epoca neotecnologica. È evidente che le categorie estetiche (espressione, stile ecc.) sopravvissute dal Rinascimento, fino allo stereotipo dell’artista maledetto e bohèmien, hanno ormai scarso significato. Nella tua analisi anche gli artisti delle nuove tecnologie – secolarizzati sperimentatori di un galleggiamento nell’universo tecnologico – non hanno più niente a che fare con gli ispirati figli di Saturno (eredità del mondo rinascimentale) e tornano ad essere pragmatici figli di Mercurio (come pittori e scultori medievali), assimilati agli orologiai e ai costruttori d’organo. Mi piace che gli artisti oggi possano essere più simili ai costruttori d’organo: ricercatori estetici, titolari di un sapere tecnico-scientifico, concentrati sui dispositivi e sulla loro fisiologia. Ma perché non pensare agli artisti come attori capaci di tenere insieme le due culture, in modo aperto e indeterminato?
Come immagini il futuro dell’arte e degli artisti? E cosa intendi quando parli degli artisti come soggetti della “domesticazione” del sublime tecnologico?
M.C.: Nulla è più lontano da me dell’idea che gli artisti abbiano esaurito il proprio compito e la loro funzione. Lo chiarisco ancora una volta perché spesso avverto del malanimo e del risentimento legati e dipendenti da questo equivoco. Da trent’anni lavoro con gli artisti e spesso li promuovo. La sola “Artmedia”, la cui prossima Edizione è prevista per i giorni dal 23 al 24 novembre <www.artmedia.unisa.it>, dovrebbe essere sufficiente a fugare ogni sospetto. Io non sono un critico d’arte, e dunque non accetto tutto quello che, di qualità, viene fatto; sono al contrario fortemente parziale e mi interessa solo quella ricerca estetica che considero in qualche modo come una sorta di filosofia applicata, di quella filosofia che ho qui appena accennato; questo significa anche che non mi interessano quegli artisti che, come ho detto, presumono di “utilizzare”, “umanizzare”, “assoggettare”… le nuove tecnologie, la qual cosa significa semplicemente far fare ai nuovi media il lavoro di quelli vecchi e riproporre con strumenti nuovi poetiche ormai esaurite e noiose. Detto questo, la tua idea dell’artista mi va perfettamente bene ed è quella che io stesso sto cercando di delineare e definire da molti anni.
Per “domesticazione del sublime” intendo poi l’esibizione dell’eccesso tecnologico nel registro dell’estetico, secondo quelle modalità alle quali ho accennato e che spero di aver anche qui in parte chiarito.
R. Ascott, Aspects of Gaia, 1989, Ars Electronica, Linz
M. Bolognini, Progetto SMSMS (serie CIMs-Collective Intelligence Machines), 2001
M. Bolognini, CIM 3, Installazione, 2004, Neon, Bologna
F. Forest, Hommage à Mondrian, 1989-2003, Museo del Sannio, Benevento
R. Kriesche, Telematic Sculture n. 4, 1995, Biennale di Venezia
M. Mitropoulos, Face to Face, 1985-2004, Museo del Sannio, Benevento