Non è, va detto, ancora molto chiaro quale pittura stia tornando in auge, date le controverse indicazioni fornite della mostra musealmente allestita da Bonami al museo Correr, appunto. Fra realismi (Guttuso) e informali (Burri), iperrealismi (Gertsch) e neominimal (Hirst), fra pop (Warhol), postpop (Kippenberger) e antipop (Gnoli), fra figurativi, nonfigurativi, astratti organici, neoconcretismi, melting pot e post-strutturalismo, tout se tient, cioè anything goes!
La questione del “perché la pittura, e quale” è cosa locale – ogni paese ha una storia pittorica diversa che riavvia per differenti motivi la macchina del dipingere- e spostare il problema dal perché farlo al consiglio per gli acquisti, come in un supermarket di lusso: l’anticamera di Christie’s, pare se non spudorato, almeno linguisticamente efferato. Non si propone una commisurazione del locale sul palcoscenico allargato e smisuratamente poliproblematico del globale, no, si azzera la problematicità locale per far brillare l’assolutezza del valore globale di mercato. A me pare; ma forse tutto va ripensato. (E, ripensandoci: chissenefrega).
Come che sia, questa pitturona come un’onda oceanica, senza direzione prestabilita, innalzata da venti contrastanti e dall’incontro di correnti opposte, marcia speditamente contromano rispetto ad un’arte del fotografico che esce dall’essere di moda e che resta lì, scomposta, assottigliata e riassorbita come il bagnato di un’onda che rifluisce dal bagnasciuga. E anzi rifluisce sotterraneamente nelle misture poliglotte delle installazioni multimediali che sono – a veder bene – la vera koinè della Biennale. Non è mai più scultura, è un “naturale” polimaterismo (da quando la natura stessa è divenuta polimaterica, e se non l’avevano capito i poveristi ce lo hanno spiegato bene artisti come Matthew Barney). E’ installazione come riallestimento del vivente, spesso mimetica fino alla sparizione, una mistura sperimentale fra media caldi e freddi.
Tuttavia, per il sollievo dei meno e l’annoiato disinteresse dei più, tutta la Biennale era punteggiata da una energica rimanenza fotografica: dalla sala dedicata alla serie dei Cowboys di Richard Prince nel Padiglione Italia alla impressionante galleria di musei e istituzioni di Candida Hšfer nel padiglione Tedesco, dalla nutrita porzione fotografica del padiglione francese allestito da Jean-Marc Bustamante a splendidi casi isolati come Paul Seawright nel padiglione del Galles alla Giudecca o il morboso Nazif Topèuoglu nel padiglione turco all’Arsenale. Così, tanto per dire.
Ma il segno che qualcosa sta cambiando a favore della pittura ce lo offre incredibilmente la pubblicità. L’immagine commerciale, per solito patinatissima e techno, ha oggi innestato una marcia indietro che come ovvio promette di portare avanti il linguaggio pubblicitario. Segnale principe è quello della vodka Absolut. Ora, non è novità che si pubblicizzi un liquore non più con scenari fantastici, immaginari mondi paralleli iperrealisti, ma con universi grafico-pittorici. Si pensi solo allo splendido lavoro realizzato da Pierluigi Toccafondo per la Sambuca Molinari. Absolut però aveva un’immagine “fredda” techno, appunto che ha contraddetto svoltando sul pittorico e facendosi consigliare da Enzo Cucchi sul nome di Andrea Salvino, neodivisionista antagonista sociale, ora alle prese, forse, con l’omologazione che questa visibilità gli porterà – volente o nolente.
E non va nemmeno trascurato di dire che il pezzo realizzato per la Absolut è un vero capolavoro, dove – un po’ seguendo il magistero dechirichiano o di Peter Halley, se vogliamo tenerci sul recente – al peggio ricalcando l’autoindulgenza di certe tele di Pintaldi – ha inserito, come soggetti complementari del suo quadro, le foto dalle quali lui stesso estrae i suoi soggetti. Vertiginoso e pure ottimamente eseguito, posso ben dirlo. Ma questo non è il solo caso: si pensi infatti alla collaborazione che Absolut ha intrattenuto con la scultrice Louise Bourgeois, canadese e novantenne, nonché geniale e strepitosa.
Ma perché tutto questo dire e disdire sulla pittura? Perché interessarci di questa fenomenologia di riflusso? O perché poi intascare il rimbrotto per l’esserci attardati sul vecchio hit-single della fotografia che oggi non tira più? Semplice: perché questo spostamento di pesi, energie, attenzioni e – purtroppo – fondi, tranne che per quest’ultima ragione, è un dato positivo per la fotografia stessa. E mi spiego. Rapidamente ma mi spiego.
Da quando lavoravo al mio “Fototensioni” per la Castelvecchi – era il 1999 – l’onda montante di omologazione e condiscendente, imbarazzato ossequio riservati alla fotografia – come mezzo o come fine, qui non andiamo troppo per il sottile – è stata a dir poco nauseante. Ricevo al giorno una media di 4/5 inviti via posta e 10 email: da quando erano di ogni genere a quando erano per l’80% basati sulla fotografia il passo è stato brevissimo. Già nel 2001 la situazione si è stabilizzata sul “tutto-foto”. Ma non per questo il dibattito si è aperto, la coscienza critica si è allargata o la frequentazione della fotografia si è fatta più filigranata.
Anzi, il grave risultato è stato che hanno percepito come un obbligo di misurarsi col fotografico sia gli esordienti in cerca di una strada, che i già esorditi in cerca di una strada alternativa a quelle sulle quali hanno riscosso poco o punto successo. E, non bastasse, si sono rivolti a questa disciplina anche degli irriducibili che per una o mezza vita hanno mangiato e bevuto tutt’altre manualità, tutt’altri problemi, tutt’altre estetiche.
Transeat: mi contenterà di citare una frase che mi disse Jeff Wall quasi dieci anni fa quando lo intervistai a Villa Medici dopo una sua conferenza: “prima di fare un lavoro mi domando se c’è una ragione squisitamente fotografica per farlo, e se non c’è non lo realizzo”. So simple, so pure. Voglio dire: la sparizione, preconizzata ma irrealizzata, del fotografico dalla Biennale e dal domani e dal dopodomani dell’arte contemporanea (magari a favore del video, no? come se…) in realtà crea un controeffetto rinvigorente ed euforizzante. Il fotografico smetterà di essere il lasciapassare di furboni e avventurieri. Chi oggi ricorre al mezzo o al fine fotografico, lo deve aver voluto, inteso e ponderato. La fotografia e tutte le sue più invereconde ibridazioni saranno, non proprio una necessità interiore come dicevano Gauguin e Kandinskij, ma almeno una necessità linguistica “cogente” (queste parole le uso sempre con circospezione).
Poi vedremo se ho ragione o se il gran caldo mi ha indotto a sbagliare analisi. E, in fondo, ripensandoci…


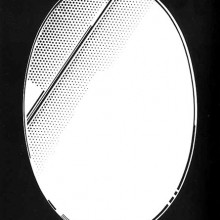






Dall’alto:
Frank Auerbach, Julia Spleeping, olio su tavola, 1978
Renato Guttuso, La Vucciria, olio su tela, 1974
Roy Lichtenstein, Mirror #2, olio e magma su tela, 1970
Damien Hirst, Abalone Acetone Powder, vernice lucida per interni su tela, 1991
Chris Ofili, Afronirvana, mat. vari ed escrementi di elefante, 2002
Richard Prince, Untitled (cowboy), C-print, 1989
Candida Hšfer, Spiegelkantine Hamburg IV, C-print, 2000
Nazif Topèouglu, A disturbing picture, C-print, 2002
Andrea Salvino, Absolut Salvino, olio su tela, 2003


